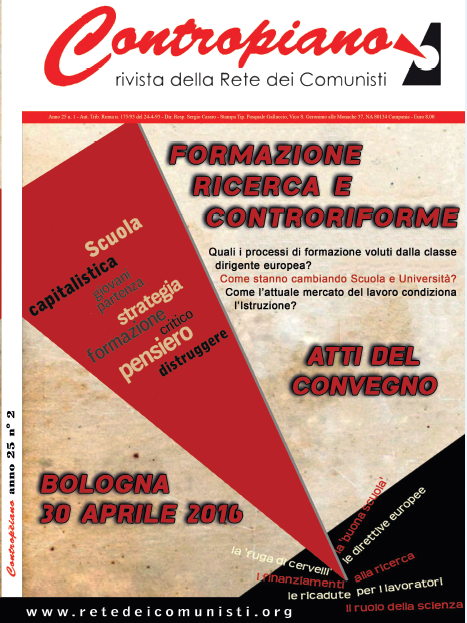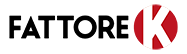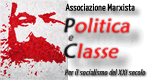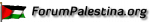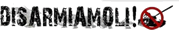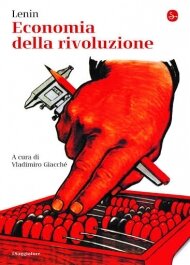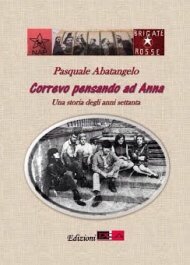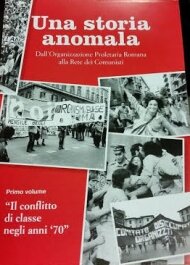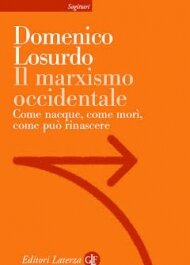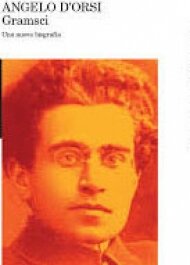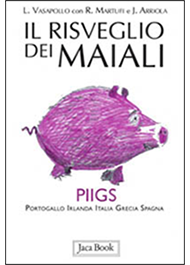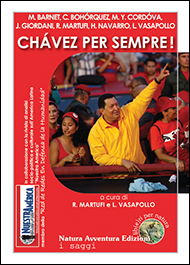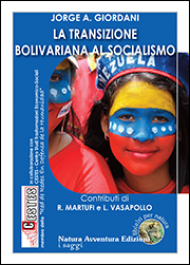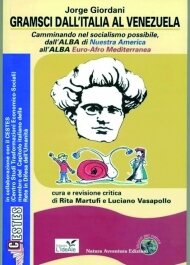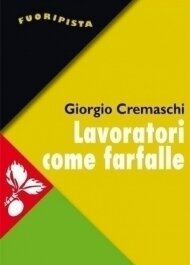Un patto Faustiano con il Neoliberismo? Ascesa e caduta dei patti sociali nella Repubblica d'Irlanda
- di Roland Erne e Vincenzo Maccarrone
- Categoria: interventi
- Visite: 3531

Fino a poco tempo quasi tutti i sindacati irlandesi hanno accettato la massima del “corporativismo competitivo”: accontentarsi di una fetta minore della torta per ricevere una torta più grande. Tuttavia, quando la bolla della “Tigre Celtica” è scoppiata e la social partnership è collassata, è divenuto evidente come gli anni della social partnership e di una crescita economica rivelatasi insostenibile avessero creato un movimento sindacale privo della sua capacità di agire in maniera indipendente. Il modello della “Tigre Celtica” può essere perciò compreso in maniera migliore se inserito nel contesto di un'applicazione pragmatica ed efficace dell'agenda neoliberale, nonostante l'inclusione dei patti sociali al suo interno sembri contraddire la teoria neoliberista.
Until very recently, most Irish trade unions resigned themselves to the ‘competitive corporatist’ maxim of: let’s accept a smaller share of the cake in order to get a bigger cake. However, when the “Celtic Tiger” bubble burst and social partnership collapsed, it became clear that years of social partnership and speculative economic growth generated a union movement that lost a lot of its capacity to act independently. The “Celtic Tiger” model is therefore best understood in terms of a pragmatic and effective adaptation of the neoliberal agenda, even if the inclusion of social pacts seems to be contradicting neoliberal theory.
Da qualunque prospettiva si guardi, l'Irlanda costituisce un interessante caso studio. Dopo decenni di stagnazione economica, che hanno spinto alcuni commentatori a coniare il termine “sottosviluppo fordista” per descrivere il periodo fra la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni '80 (Ò Riain, 2004), le 26 contee hanno sperimentato vent’anni di strepitoso sviluppo. Alti tassi di crescita, bassa disoccupazione e inversione del flusso migratorio caratterizzarono il ventennio che è stato definito della “Tigre Celtica”, durante il quale la dinamicità dell'economia irlandese ricordava quella delle quattro Tigri asiatiche. Tuttavia, come fu repentina la crescita, lo fu anche il crollo.
La crisi economica mondiale tuttora in corso ha colpito più duramente di altri la Repubblica, troppo dipendente dagli investimenti stranieri esteri (IDE) e dotata di un sistema finanziario rivelatosi assai debole. Gli IDE hanno incrementato lo stock di capitale produttivo, ma hanno contribuito a determinare la bolla finanziaria e immobiliare che ha portato al collasso delle banche irlandesi nel 2008[1]. Da allora l'Irlanda ha sperimentato uno dei più costosi salvataggi bancari della storia[2], disoccupazione di massa, emigrazione, pesanti tagli al welfare, stipendi e spesa pubblica, insieme ad aumenti delle imposte che il governo ha messo in atto sin dal 2009 in collaborazione con la troika FMI- Unione Europea- BCE. Di conseguenza le prospettive di rilancio del paese appaiono all'oggi ancora molto incerte.
Che tipo di modello di sviluppo economico, politico e sociale ha caratterizzato la Repubblica d'Irlanda nell'ultimo ventennio? È stato il modello neoliberista, adottato dalla vicina Gran Bretagna, o quello neo-corporativo a prevalere? Nei paragrafi che seguono proveremo a rispondere a questa domanda.
Crisi nel neoliberismo o crisi del neoliberismo?
La crisi ancora in corso ha messo in discussione il modello neoliberista. I lavori seminali di Dumenil e Levy (2004) e Harvey (2005) definiscono il neoliberismo come un ordine sociale e un regime di accumulazione emerso fra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 del secolo scorso in Gran Bretagna e Stati Uniti, e diffusosi poi in ampie parti del mondo nel trentennio successivo. Il neoliberismo, in questa visione, si caratterizza non tanto e non solo come teoria economica, ma anche e soprattutto come «progetto politico che mira a ristabilire le condizioni per l'accumulazione e a ripristinare il potere delle élite economiche» (Harvey, 2005, p. 19), nato sia in risposta all'eccessivo potere guadagnato dalla popolazione lavoratrice durante il compromesso Keynesiano a seguito della II Guerra Mondiale sia come soluzione ai problemi nel processo di accumulazione di capitale durante la stagflazione degli anni '70.
Se ben poco ha fatto la contro-rivoluzione neoliberista per risolvere i problemi di accumulazione del capitale – Harvey (2005) annota come i tassi di crescita del PIL globale dagli anni '80 in poi siano stati inferiori a quelli del trentennio post-bellico – lo stesso non si può dire per quanto concerne la restaurazione del potere di classe. Crescenti diseguaglianze e spostamenti a favore della quota-profitti sono stati caratteristici dei paesi che hanno adottato l'agenda neoliberale. A questo vanno aggiunte le privatizzazioni di numerose imprese statali, la liberalizzazione degli spostamenti di merci e capitali, l'enfasi monetarista sul controllo dell'inflazione e sull'applicazione di politiche economiche dal lato dell'offerta, la deregolamentazione dei mercati e la mercificazione della società (ad esempio tramite processi di privatizzazione della spesa sociale) (Birch e Mykhnenko, 2010).
La crisi, ad ogni modo, ha messo in discussione la teoria neoliberista ma non la sua prassi. È infatti in atto una crisi nel modello di accumulazione neoliberista, ma non del modello di accumulazione neoliberista (Saad-Filho, 2011). Le politiche di austerità praticate dalla troika e dai governi europei in risposta alla crisi dimostrano come sia ancora lontana la nascita di un nuovo paradigma economico e politico in risposta ai profondi sconvolgimenti economici, politici e sociali che stiamo vivendo, come era accaduto nel 1929 con il Keynesismo, e negli anni '70 con il Neoliberismo stesso. Laddove la crisi ha portato alla sostituzione delle politiche di lassez-faire con un modello di governo dell'economia più intervenzionista e post-democratico, il progetto neoliberale è ancora presente (Erne 2012; 2011b). Nel prossimo paragrafo proveremo ad inserire la Repubblica d'Irlanda all'interno di questa cornice di analisi.
Il neoliberismo irlandese
Se si dovesse datare con una certa precisione l'inizio della svolta neoliberista nella Repubblica d'Irlanda si potrebbe prendere come anno simbolo il 1989. È in quell'anno infatti che salì al governo la coalizione composta da Fianna Fáil[3]e Progressive Democrats (PD). Quest'ultimo partito, di ispirazione thatcherista, era nato nel 1985 da una scissione a destra dello stesso Fianna Fàil, il più influente partito nella storia repubblicana. I membri del PD esaltavano l'impresa privata, l'etica e la trasparenza nelle cariche pubbliche e ad aderivano ad una visione liberal sui diritti civili (erano, ad esempio, favorevoli al divorzio) (Ferriter, 2004). La coalizione mise in atto una serie di misure di austerità per far fronte all'incremento del debito pubblico accumulato negli anni '70-'80 nonostante Charles Haughney, il leader del Fianna Fáil, avesse in precedenza criticato aspramente le politiche monetariste della coalizione composta da Fine Gael[4]e Labour, definendole portatrici di “alienazione e disordine sociale” (citato in Allen, 2005, 23). Il ventennio successivo porterà all’implementazione di una serie di politiche del tutto coerenti con l'agenda neoliberale.
Sotto svariati aspetti la Repubblica d'Irlanda ha infatti seguito l'esempio di paesi in cui si erano affermate politiche neoliberiste. Primo, a partire dagli anni '90 dieci imprese di proprietà statale sono state privatizzate, nonostante avessero generalmente conseguito risultati soddisfacenti (Sweeney, 2005), con il consenso iniziale dell’Ictu[5] (O'Connor, 2011). I leader sindacali presero parte al Nation Competitiveness Council, incaricato di promuovere la concorrenza in tradizionali monopoli naturali, come i settori dell'energia e le telecomunicazioni. Negli anni 2000, però, essi si allontanarono da questa posizione (Sweeney 2005). I risultati delle privatizzazioni sono stati ambigui, e in alcuni casi si sono conclusi con un vero e proprio fallimento, come nel caso di Eircom, la compagnia irlandese di telecomunicazioni.[6]
Secondo, la modulazione del sistema tributario irlandese favorisce inevitabilmente l'accumulazione di ricchezza da parte delle élite. Esso è basato in maniera sproporzionata sulla tassazione indiretta, che incrementa la regressività del prelievo. L'Irlanda presenta inoltre la più bassa imposta sulle imprese in tutta Europa (Hardiman, 2002b), il che favorisce le grandi multinazionali straniere desiderose di investire in Europa. Le svariate esenzioni fiscali e i condoni per gli evasori concludono un quadro quantomeno favorevole ai detentori di alti redditi (Allen, 2007; Hardiman, 2002b).
Terzo, la regolamentazione delle operazioni finanziarie e del mercato del lavoro è stata progressivamente “alleggerita” (McDonough e Dundon, 2010). La scarsa disciplina del mercato finanziario, vista come chiave per attrarre gli investimenti esteri, ha mostrato tutta la sua debolezza durante la crisi economica, in cui si sono susseguiti costosi salvataggi delle banche a spese dei contribuenti.
Tutti questi elementi hanno avuto l'effetto di incrementare le diseguaglianze sociali nella Repubblica d'Irlanda, come già avvenuto in paesi come Gran Bretagna e Stati Uniti. Benché vi siano autori, come Teague e Donaghey (2009), che sostengono che la disuguaglianza in Irlanda non sia aumentata nell'ultimo ventennio, ciò non pare confermato dall'analisi empirica. McDonough e Loughrey (2009) nella loro analisi mostrano come, insieme ad un miglioramento generale delle condizioni di vita, il gap fra redditi alti e redditi bassi è aumentato in maniera considerevole in Irlanda fra il 1987 e il 2005. Kirby e Murphy (2011) indicano come causa della crescente disuguaglianza non solo la natura stessa del neoliberismo, che tende ad incrementare le disuguaglianze fra lavoratori qualificati e non, ma anche le politiche del governo in materia di regolamentazione tributaria e del mercato del lavoro, favorevoli alle classi più abbienti. A questi dati vanno aggiunti quelli sul patrimonio: l'uno per cento più ricco della popolazione negli anni '90 ha raddoppiato la sua percentuale di ricchezza detenuta rispetto agli anni '70 e '80 (Kirby, 2009). Una ricerca della Bank of England del 2007 mostra che il cinque per cento della popolazione detiene i due terzi della ricchezza irlandese (Kirby e Murphy, 2011).
Esiste tuttavia un grosso nodo teorico da affrontare per potere inserire la Repubblica d'Irlanda in un cornice di analisi sul neoliberismo. Esso è il modello di relazioni industriali adottato dalle 26 Contee, ossia la social partnership. A partire dal 1987, anno in cui fu siglato il primo accordo, si sono susseguiti sette accordi nazionali fra Stato, sindacati ed imprese. Inizialmente essi erano limitati ad un accordo di moderazione salariale per i lavoratori in cambio di tagli alle tasse, insieme ad alcune clausole legate ai livelli occupazionali e al welfare; in seguito l'area di competenza dei patti si è ampliata, anche in risposta ai cambiamenti avvenuti nel corso degli anni (Roche, 2012).
Tale caso è evidentemente in contrasto con il modello classico di relazioni industriali neo-liberista: quest'ultimo prevede infatti una contrattazione decentrata e a livello individuale (Roche e Cradden, 2003; Hardiman, 2002a). La contrattazione nazionale collettiva è vista come pericolosa portatrice di aumenti di spesa pubblica, mentre la contrattazione individuale e aziendale rifletterebbe la “realtà economica” dei diversi settori e delle diverse imprese (Roche e Cradden, 2003). I mercati del lavoro vanno liberati il più possibile da “rigidità” quali il salario minimo o le leggi sulla flessibilità in entrata o in uscita. Il potere dei sindacati va diminuito, a vantaggio di una contrattazione individuale fra lavoratore e datore di lavoro. È possibile quindi parlare di svolta neoliberista in Irlanda nonostante la presenza dell'istituto della social partnership? Il paragrafo che segue prova ad affrontare la questione.
Ascesa e declino della social partnership
Le radici della social partnership affondano nei decenni precedenti. Già negli anni '50 una serie di pay rounds concernenti il livello del salario avevano segnato l'inizio di una centralizzazione delle RI (O' Connor, 2011). Ad esse avevano fatto seguito negli anni '70 i National Wage Agreements (NWA), che fissavano i tassi di incremento del salario per l'intera forza lavoro nazionale in tutti i settori (Von Prondzynski, 1998). Nel 1979 essi furono incorporati in un quadro più ampio, il National Understanding for Economic and Social Development, che riguardava aspetti quali la tassazione, l'occupazione e la questione abitativa. Al primo National Understanding fece seguito un secondo nel 1980, il terzo, invece, non vide mai la luce. Da un lato, la crisi economica che colpì la Repubblica d'Irlanda nel corso degli anni '80 fece sì che il governo non potesse mantenere gli impegni presi. Dall'altro, gli imprenditori erano decisi ad ottenere una contrattazione a livello aziendale, a loro più favorevole (O'Connor, 2011). Negli anni '80 si ritornò quindi ad una contrattazione decentrata. Ciò favorì uno spostamento dei rapporti di forza a favore dei datori di lavoro, elemento che sarebbe stato in seguito fondamentale per convincere i sindacati a prendere parte al primo accordo di social partnership(Roche, 2007). Nel periodo 1981-1987 la disoccupazione raggiunse picchi del diciannove per cento, il salario reale diminuì del sette per cento e l'emigrazione tornò a salire, mentre il rapporto debito pubblico su PIL aveva raggiunto quota 150 per cento. L'affiliazione ai sindacati crollò e con essa il numero di scioperi (O'Connor, 2011). Queste le condizioni in cui il Programme for National Recovery – il primo accordo di social partnership – vide la luce.
Nel 1987 il governo di minoranza a guida Fianna Fáil si era appena insediato. Benché negli anni '70 tale partito avesse sostenuto una politica di stampo prettamente Keynesiano per far fronte alla “stagflazione”, esso si trovava ora a dover praticare una politica di austerità, in una situazione di profonda crisi economica e sociale, cercando al contempo di evitare uno scontro coi sindacati (specie quelli, storicamente combattivi, dei servizi pubblici) (Roche, 2007).
Per parte loro, i sindacati irlandesi si trovavano a fronteggiare diversi problemi. La contrattazione deregolamentata aveva portato ad un aumento delle diseguaglianze ed ad una diminuzione del salario reale, minacciando la coesione fra i lavoratori. A questo bisogna aggiungere che, sotto gli accordi tripartiti, i lavoratori meno pagati erano stati protetti dagli incrementi del salario minimo. Gli anni '80 avevano poi visto un deciso calo degli iscritti al sindacato (il dato più basso dagli anni '20) e della densità sindacale (Roche, 2007). Infine, vi era la paura di una deriva di stampo neoliberista delle relazioni industriali in Irlanda, visti i crescenti consensi catalizzati dal PD, che aveva raggiunto l'11.9 per cento alle elezioni del 1987 (più del Labour), e lo spostamento verso posizioni neo-liberiste del Fine Gael, il secondo partito per importanza (Roche e Cradden, 2003; Roche, 2007; Ferriter, 2004). Si trattava di scegliere, per usare le parole di O' Connor (2011), fra una “Celtic Tiger” e una “Celtic Thatcher”: il sindacato scelse la prima via. Il Fianna Fáil, forte della sua relazione storica con le organizzazioni dei lavoratori, fu così in grado di convincere i sindacati a prendere parte all'accordo (Ferriter, 2004).
A prima vista, i datori di lavoro non avrebbero avuto tangibili guadagni nel passare da una contrattazione deregolamentata ad un accordo tripartito centralizzato. Come ricordato, la bilancia dei rapporti di forza fra 1980 e 1987 pendeva nettamente a favore delle imprese. Tuttavia, la situazione macroeconomica complessiva, con alta inflazione e alto debito pubblico, costituiva motivo di preoccupazione per le imprese e un accordo tripartito sembrava offrire la possibilità di legare la moderazione salariale con le riforme economiche ritenute necessarie per il paese (Roche e Cradden, 2003; Roche, 2007). Convinti dall'insistenza del An Taoiseach[7] Charles Haughney, anche i rappresentanti delle imprese aderirono al PNR (così come le associazioni dei coltivatori). L'organo più rappresentativo degli imprenditori coinvolto nel processo di social partnership fu l'Irish Business and Employers Confederation (IBEC), presente pressoché in tutti i settori, ad esclusione di quello delle costruzioni, in cui l'organismo più importante è la Construction Industry Federation, coinvolta a partire dagli accordi successivi (Roche, 2007).
Il PNR era un accordo su base triennale il quale prevedeva che gli incrementi salariali non dovessero superare il 2.5 per cento in ciascun anno del triennio 1988-1990, con una clausola speciale per i bassi salari, che lasciava la possibilità di un incremento maggiore (Von Prondzynski, 1998). In cambio di queste limitazioni, il governo promise un pacchetto di tagli alle tasse per un totale di 225 milioni di sterline per l'intero periodo dell’accordo. Il piano fissava poi alcuni obiettivi in termini di numero di posti di lavoro, oltre a diminuire l’orario lavorativo settimanale da 40 a 39 ore (Hardiman, 2002a). Contestualmente all'accordo il governo mise in atto un piano di abbattimento della spesa pubblica per 900 milioni di sterline, iniziando così una politica di riduzione della spesa portata avanti anche dal successivo governo di coalizione Fianna Fail-PD. Aiutato dalle circostanze economiche nazionali ed internazionali che abbiamo descritto in precedenza, il PNR ottenne i risultati prefissati: l'andamento degli aumenti salariali a livello locale seguì il percorso tracciato dal PNR, e anche i requisiti in termini di creazione dei posti di lavoro nel settore privato furono rispettati (Von Prondzynski,1998).
Dal 1987 ad oggi sono stati negoziati sette accordi di partnership.Il mutare delle condizioni socioeconomiche durante gli ultimi due decenni ha fatto sì che vi fosse un cambiamento nelle priorità degli accordi. Se i primi patti erano focalizzati sulla risoluzione di una situazione di crisi economica, quelli successivi presero in considerazione problemi relativamente nuovi, come la gestione del processo di crescita o il soddisfacimento dei criteri per l'ingresso nell'Unione Monetaria Europea (Roche, 2007; O'Connor, 2011).
McDonough e Dundon (2010) e Von Prondzynski (1998) riassumono le caratteristiche del sistema di relazioni industriali (RI) durante la social partnership nel modo che segue. Primo, il sistema di RI irlandese è volontarista: le parti regolano le condizioni di lavoro tramite la contrattazione collettiva, piuttosto che tramite accordi legislativi. Secondo, esso è antagonista: si riconosce che un conflitto di interessi fra le parti è insito in tale sistema. Ciò spiega il diffuso ricorso alla contrattazione collettiva (Collings, Gunnigle e Morley, 2008).[8]
Le parti quindi riconoscono che la mediazione dello Stato può essere importante, tramite organi come la Labour Court[9]. Terzo, il sistema è centralizzato e istituzionalizzato: la contrattazione a livello locale ha poca importanza e, comunque, tende a seguire il trend fissato a livello centrale. Inoltre, esso si basa su un insieme di istituzioni, come la già citata Labour Court o la Labour Relations Commission[10], per la risoluzione dei conflitti. Infine, il sistema è collettivista, nel senso che riconosce l’importanza della rappresentanza collettiva degli interessi degli individui: livelli storicamente alti di densità sindacale, accettazione del ruolo dei sindacati nei processi decisionali sulle RI, importanza della contrattazione collettiva ne sono elementi caratterizzanti (Collings, Gunnigle e Morley, 2008).
Il meccanismo istituzionale della social partnership ha resistito per oltre 20 anni, smentendo coloro che sostenevano che, con la ripresa della crescita economica negli anni 2000, l'Irlanda sarebbe andata verso un tipo di contrattazione decentrato più simile a quello britannico (Roche, 2012). Tuttavia lo scoppio della crisi economica ha segnato anche la fine, quantomeno momentaneamente, della SP. L'ultimo accordo siglato, Towards 2016, era stato rinegoziato nel 2008 a seguito dell’avvento della crisi. Ad ogni modo , a fine 2009 il governo chiese un'ulteriore ridiscussione dei patti, ma le parti non furono in grado di raggiungere un accordo sui tagli proposti in maniera unilaterale dall'esecutivo (fra cui un taglio 15 per cento del salario dei dipendenti del settore pubblico) (McDonough e Dundon, 2010, Regan 2012). In seguito, il Governo ha imposto il taglio dei salari pubblici proposto in precedenza , causando uno sciopero nazionale di un'intera giornata e una campagna durata tre mesi di “sciopero bianco” nel settore pubblico.
Nel tentativo di uscire da questo vicolo ciecoe ridare linfa agli accordi disocial partnership,è stato negoziato un accordo che riguarda il settore pubblico, il “Public Service Agreement 2010-2014 (Croke Park Agreement)”. Nell’accordo il governo si è impegnato a non applicare ulteriori tagli salariali né licenziamenti unilaterali fino al Giugno 2014, anche se esso prevede che si continui il blocco del turnover e che, dove possibile, vengano messi in atto meccanismi per facilitare esuberi volontari. In cambio, i sindacati hanno dovuto accettare le misure di austerità ed il piano di modernizzazione della pubblica amministrazione proposto dal governo, che ha portato, fino a Dicembre 2011, a 1.49 miliardi di Euro di risparmio sui costi del personale e a una riduzione della forza lavoro nel settore pubblico dell'8,8 per cento (Sheenan, 2012).
Tuttavia, nel Febbraio 2013 il governo ha cercato di sostituire l'accordo di Croke Park con un nuovo accordo, il “Croke Park 2” (Labour Relations Commission 2013). L'esecutivo ha annunciato ai leader dei sindacati che il nuovo accordo avrebbe dovuto includere un ulteriore risparmio di un miliardo di euro per le casse dello stato e li ha minacciati di imporre direttamente per legge un taglio dei salari pubblici del 7 per cento se i negoziati non fossero andati a buon fine. I leader sindacali hanno risposto alle pressioni del governo negoziando un nuovo accordo che prevede il risparmio richiesto. Le riduzioni salariali addizionali colpiranno però i dipendenti pubblici in maniera diseguale. La maggior parte dei risparmi verrà da sezioni specifiche del settore pubblico, ovvero da coloro che lavorano nei turni serali, notturni o festivi, oppure dai lavoratori che guadagnano più di 65.000 euro lordi l'anno. Nel momento in cui scriviamo i sindacati del settore pubblico stanno consultando i loro iscritti riguardo al nuovo accordo. Se la maggioranza dei tesserati dei sindacati facenti parte dell'ICTU appoggerà il “Croke Park 2”, esso entrerà in vigore il 1 Luglio 2013. I leader dei due maggiori sindacati del settore pubblico, SIPTU e IMPACT, chiedono gli iscritti di votare sì all'accordo, in considerazione del loro impegno di lunga data a favore della social partnership ma anche perché essi rappresentano lavoratori che soffriranno meno le conseguenze diseguali a cui abbiamo accennato. Dato che questi due sindacati controllano circa il 50 per cento del voto per delega all'interno dell'ICTU, è probabile che l'accordo verrà approvato dal comitato del settore pubblico, anche se la maggioranza dei lavoratori pubblici iscritti al sindacato e la maggioranza dei membri dell'ICTU votassero per respingere l'accordo[11]. A loro volta però la maggior parte dei sindacati della Sanità e della Scuola, insieme alle compagini sindacali più tradizionalmente di sinistra (UNITE e CPSU), hanno annunciato che un'approvazione dell'accordo da parte dell'ICTU contro la volontà degli iscritti potrebbe portare ad una rottura della confederazione (Erne, 2013). Allo stato dell'arte la possibilità di nuovi accordi di social partnership appare pertanto molto difficile.
Differenti visioni sulla social partnership
Il tema della social partnershipè stato affrontato da diversi commentatori. Nel seguente paragrafo si proveranno ad identificare le principali analisi emerse. Teague e Donaghey (2009) definiscono la social partnership come una delle “complementarietà istituzionali”, ossia una varietà di istituzioni combinate per creare una serie di effetti dinamici. In questo contesto, la presenza di una istituzione incrementa l'efficacia di un'altra. Per gli autori, la social partnership si è connessa positivamente con altri aspetti dell'economia irlandese, creando un regime peculiare di crescita economica fondamentale per la nascita della “Tigre Celtica”. In particolare, la SP si inserisce in un circolo virtuoso che coinvolge altri due aspetti dell'economia irlandese: l'apertura dei mercati e uno stato sociale minimo. La SP avrebbe favorito l'apertura dell'economia irlandese, contribuendo a mantenere un regime di moderazione salariale e un'evoluzione delle relazioni di lavoro che, insieme alla bassa tassazione delle imprese, hanno contribuito ad attrarre gli IDE, fondamentali per garantire la crescita economica irlandese. La vigorosa crescita economica della “Celtic Tiger” ha garantito il mantenimento di un welfare state minimo. Per Teague e Donaghey, la chiave della sopravvivenza della SP rispetto ad altri regimi simili instauratisi in Europa è la sua natura non redistributiva. Storicamente, questi accordi prevedevano che, in cambio di moderazione salariale, i sindacati ottenessero aumenti di spesa pubblica. La social partnership ha garantito invece un incremento del consumo privato, tramite la riduzione delle imposte, senza quindi focalizzarsi sulla creazione di un esteso stato sociale: questo avrebbe favorito la permanenza dei datori di lavoro all'interno degli accordi. Ciò ha significato uno spostamento dei rapporti di forza a favore delle imprese ma, sostengono i due autori, non un significativo aumento delle disuguaglianze sociali (supra).
L'analisi di Teague e Donaghey contiene sicuramente alcuni spunti interessanti come il riconoscimento del ruolo giocato dalle multinazionali USA nello sviluppo irlandese e il ruolo della SP nell'attrarle. Tuttavia non si può tralasciare come la tempistica delle considerazioni degli autori sia stata quantomeno sfortunata. Nemmeno un anno dopo la pubblicazione dell'articolo, la SP è collassata. Come fa notare Roche (2012), non è avvenuto negli anni recenti alcun cambiamento all'architettura istituzionale, ritenuta dagli autori essere il motivo della persistenza della SP, che possa giustificare la sua improvvisa caduta. La spiegazione della SP come “complementarità istituzionale” appare quindi gravemente compromessa.
Può anche esservi stata una relazione pro-ciclica fra l'obiettivo della social partnership di ridurre la tassazione e l'ascesa della Tigre Celtica, ma questa relazione si è dimostrata insostenibile. Non appena la crisi ha portato al netto declino dei ricavi dalla tassa sulla proprietà, il governo ha incrementato le imposte, aggravando la recessione. Il “successo” della Tigre Celtica si è basato anche su una vasta espansione del debito privato per sostenere la domanda aggregata e proteggere la popolarità del Fianna Fáil, nonostante gli impegni assunti negli accordi di social partnership circa la moderazione salariale e lo stato sociale minimo.
La visione portata avanti da autori di formazione marxista e dipendentista come Allen (2000, 2003), O'Hearn (2003) e, più recentemente, da McDonough e Dundon (2010), è quella della SP come “ neoliberismo dissimulato” o “thatcherismo ritardato”.
Secondo gli autori, già da prima del 1987 il governo irlandese ha portato avanti una politica di ristrutturazione del movimento sindacale, così da soddisfare i bisogni del capitalismo irlandese. La SP, in questa visione, sarebbe stata funzionale ad “incorporare” i leader sindacali, così che essi arrivassero a condividere la visione e gli obiettivi dei membri del governo e dei datori di lavoro. Secondo Allen (2003), questo era necessario per tre ordini di motivi: garantire la mancanza di conflitto industriale; cambiare le pratiche di lavoro e così aumentare la produttività e la flessibilità; assicurare la moderazione salariale.
Il risultato, secondo gli autori, è stato quello di creare una “maggioranza scontenta” di lavoratori e cittadini: la disuguaglianza dei redditi è cresciuta, la spesa sociale tagliata, il tutto a vantaggio delle frazioni più privilegiate della società. In questo senso, la SP si caratterizza per il suo successo ideologico nel cooptare la potenziale opposizione per le crescenti disuguaglianze sociali. McDonough e Dundon (2010) riconoscono che la SP ha protetto i lavoratori dai peggiori eccessi tipici dell'applicazione di un modello di relazioni industriali neoliberista. Tuttavia, il patto sociale così costituito ha permesso lo sviluppo di un modello di accumulazione che si è dimostrato alla fine insostenibile. La crisi, che ha mandato in frantumi la SP, ha fatto così riallineare la Repubblica d'Irlanda alle caratteristiche del neoliberismo globale. Da qui la definizione di “thatcherismo a scoppio ritardato”.
Al contrario Roche (2007; 2012) riporta i dati di diverse ricerche che mostrano un deciso supporto per la SP, sia fra gli iscritti al sindacato, sia nella popolazione più in generale, benché i cittadini fossero consapevoli della diseguale spartizione dei benefici della crescita.
Mentre la maggioranza dei membri dei sindacati del settore pubblico e del più grande sindacato generalista irlandese, il SIPTU, ha ripetutamente votato a favore degli accordi di social partnership, la gran parte dei sindacati che rappresentano singole professioni (per esempio il sindacato degli elettricisti TEEU) nel settore privato si è opposta a questi accordi. Data l'enorme crescita dei profitti in questo settore, queste compagini potevano credere legittimamente che avrebbero guadagnato di più da accordi decentralizzati, piuttosto che da accordi centralizzati. Eppure questi membri “anti-social partnership” accettarono l'autorità dell'Ictu nel prendere la decisione finale circa il comportamento di tutti i suoi affiliati sulla questione (Baccaro e Simoni 2007).
Questi dati sembrano dunque contraddire l'idea di una “maggioranza scontenta” della SP portata avanti in particolare da O' Hearn e Allen. Roche mette in discussione anche l'argomento sull'incorporazione dei leader sindacali, quantomeno a livello aziendale, anche se la tesi di Allen al riguardo è più difficile da confutare. Per quanto riguarda il quadro nazionale, indubbiamente i leader del sindacato hanno goduto della possibilità di esercitare un maggiore controllo sui livelli inferiori delle proprie organizzazioni (Roche, 2012). Ciò nonostante la partnership aziendale a livello privato ha ottenuto riscontri piuttosto modesti, e nei pochi casi in cui é stata applicata i risultati di solito sono stati positivi per la forza-lavoro (Roche, 2007; 2012).
Più complesso appare il discorso a livello di partnership sul luogo di lavoro nel settore pubblico, dove certamente l'impatto della SP è stato significativo (Roche e Geary 2006). La ricerca empirica di Doherty ed Erne (2010) evidenzia che la SP è stata usata per facilitare l'implementazione di pratiche manageriali per la “modernizzazione” dei servizi pubblici, più che per giungere a decisioni condivise. Inoltre, il governo ed i suoi organi, in particolare le due agenzie statali che si occupano di lavoro (FAS) e di sanità (HSE), hanno cooptato nei consigli direttivi funzionari del sindacato e hanno finanziato costosi corsi di formazione all'estero, per “incrementare la comprensione da parte dei sindacati dell'agenda del cambiamento proposta dalle imprese” (Allen 2011, 184). Tuttavia, i sindacati non sembrano tanto soffrire di “incorporazione”, quanto di incapacità di collegare adeguatamente partnership nazionale e partnership a livello locale. Infine, Roche contesta l'idea che i leader sindacali possano imporre decisioni agli iscritti: l'esperienza mostra come gli membri del sindacato siano riusciti a forzare i propri leader, seppur riluttanti, ad abbandonare il tavolo della trattativa sugli accordi di SP se ritenuti contrari ai propri interessi (Roche, 2012).
Il contesto più appropriato in cui inserire la social partnership appare dunque quello del neo-corporativismo. Nel neo-corporativismo classico, lo Stato si impegnava a garantire un bilanciamento di poteri fra interessi sociali antagonisti fra Capitale e Lavoro (Erne, 2011a). I sindacati accettavano accordi tripartiti su salari e prezzi atti a limitare l'inflazione, in un contesto però di uno Stato forte che interveniva per promuovere politiche di crescita economica, pieno impiego ed equa redistribuzione dei redditi. Benché i paesi che avevano adottato politiche di questo tipo sembrassero aver resistito meglio di altri alla crisi degli anni '70, il neo-corporativismo classico entrò in crisi negli anni '80, sotto la pressione della trans-nazionalizzazione della produzione e la flessibilizzazione dei contratti, che rendeva più complicata l'azione dei sindacati (Schmitter e Grote, 1997).
Nonostante il neo-corporativismo sembrasse definitivamente tramontato, a fronte dell'avanzare del modello di relazioni industriali decentrato, specie nei paesi anglosassoni, esso tornò nuovamente in auge negli anni '90. Ad ogni modo le caratteristiche del modello erano mutate, tanto che esso è stato rinominato “neo-corporativismo competitivo”. Esso non è altro che una strategia che trasferisce la logica microeconomica della competizione fra imprese ad un livello macro, fra stati-nazione. Il principio guida di questi patti diviene la competitività (Erne, 2010). La negoziazione tripartita non riguarda più soltanto salari e prezzi, ma anche riforme del welfare e del mercato del lavoro per promuovere flessibilità ed incrementare la qualità della forza-lavoro. Il punto di vista favorito diviene quello dell'impresa. Negli anni '90, ben 7 sui 14 paesi membri dell'Unione Europea analizzati da Erne (2010) adottarono una politica di moderazione salariale competitiva in un contesto di patti sociali di questo tipo. Fra questi l'Irlanda.
Benché priva di quelle che sono comunemente considerate le precondizioni per l'affermarsi di un modello come il “neo-corporativismo classico”, fra cui ad esempio il monopolio di rappresentanza da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro e degli industriali e un sistema politico con partiti socialdemocratici, l'Irlanda ha seguito il percorso di altri paesi come l'Italia negli anni '90, uscendo da una profonda crisi economica con un modello di relazioni industriali ascrivibile al “neo-corporativismo competitivo”. Hardiman (2002a) elenca in particolare tre “catalizzatori” per lo sviluppo del sistema di neo-corporativismo. Primo, la grave situazione di crisi economica. Come nota Erne (2010), più che la competitività fu essa una delle prime ragioni per implementare la SP in Irlanda. Secondo, l'interazione fra le istituzioni del mercato del lavoro e gli altri attori della politica economica, come ad esempio la politica monetaria. Il mantenimento della credibilità della valuta irlandese prima, e l'accettazione dei criteri di Maastricht poi, costituirono un elemento di rinforzo del neo-corporativismo competitivo. Terzo, l'accordo fra i partiti sul ruolo della social partnership: dal 1987, tutti i maggiori partiti hanno governato in coalizione, sostenendo la SP.
L'evoluzione degli accordi successivi di SP ha sostanzialmente confermato questa visione. Come abbiamo analizzato in precedenza, la necessità di mantenere la competitività non si è affievolita, ma è anzi rimasta anche quando l'Irlanda ha fatto il suo ingresso nell'UME. Gli obiettivi di eguaglianza o di miglioramento della qualità della vita, come accaduto anche negli altri paesi con un modello simile, sono rimasti in secondo piano, dando forma e sostanza alla definizione di O' Riain (2004) della social partnership come “solidarietà senza eguaglianza”.
Il neoliberismo irlandese e la SP: "Neoliberismo pragmatico"?
A prima vista, la tesi sul neo-corporativismo competitivo come spiegazione della SP sembrerebbe poter minare l'argomentazione che ci sia stata una svolta neoliberista in Irlanda. Tuttavia un'analisi più articolata mostra che non è così.
In primo luogo, lo sviluppo del neoliberismo a livello globale è stato diseguale e non tutti i paesi hanno compiuto una applicazione completa della agenda neoliberale. Come ricorda Harvey (2005), il contesto istituzionale, storico e sociale influisce sul modo in cui si sviluppa una varietà di neoliberismo e lo ha certamente fatto anche nel caso della Repubblica d'Irlanda. Bisogna considerare, ad esempio, come sia sempre stata la questione nazionale, e non la storica divisione destra-sinistra, il terreno di scontro fra le forze politiche nella Repubblica d'Irlanda. Si deve inoltre tenere conto delle influenze che il modello sociale europeo ha avuto sulle decisioni di politica economica e sociale, di cui certamente la social partnership costituisce l'evidenza più grande. O'Toole (2003) ricorda anche, contrariamente a quanto sostengono gli economisti ortodossi, che uno dei catalizzatori della crescita economica degli anni '90 fu uno Stato interventista, più che uno Stato leggero.
Tuttavia questi aspetti rientrano nella tensione fra neoliberismo nella teoria e neoliberismo nella prassi. Harvey (2005, p. 19) ricorda che: «la realtà suggerisce (...) che quando i principi neoliberisti si scontrano con il bisogno di restaurare o sostenere il potere dell'élite, allora i principi sono o abbandonati o così cambiati da apparire irriconoscibili». Da questo punto di vista, la manifestazione più evidente di questo “tradimento” della teoria nella Repubblica d'Irlanda sono stati i salvataggi statali di grandi banche come la Anglo-Irish Bank, laddove secondo la teoria neoliberista, nel caso di perdite dovute a cattivi prestiti, dovrebbe essere il creditore a sopportarle. Anche l'interventismo statale può essere compreso attraverso l'uso di questa categoria. I teorici neoliberali sostenevano la necessità di ridurre il ruolo dello stato, in quanto portatore di pericolose distorsioni nelle decisioni degli agenti economici e per la minaccia alla libertà individuale insita nelle sue azioni. Tuttavia, la svolta conservatrice è avvenuta anche grazie all'attivo ruolo dello stato, ad esempio nel diminuire il potere dei sindacati (Harvey, 2005). Da questo punto di vista, se l'apertura dei mercati irlandesi facilitava le condizioni per l'accumulazione di capitale delle élite straniere e locali, non si vede perché lo stato irlandese sarebbe dovuto rimanere inerte.
Questo ci riporta alla definizione del neoliberismo prima di tutto come manovra di classe. Certamente il modello di relazioni industriali rappresentato dallasocial partnership è assai lontano dalla teoria neoliberista delle IR. Eppure i suoi risultati sono stati tutt'altro che sfavorevoli per il Capitale nella bilancia dei rapporti di forza fra Capitale e Lavoro. I dati della Commissione Europea mostrano che, mentre per tutti gli anni '80 la quota- salario rispetto al PIL in Irlanda è rimasta poco al di sotto di quella europea (71.2 per cento, a fronte di una media europea del 71.8), fra 2001 e 2007 essa è passata ad essere nettamente più bassa (54.34 per cento a fronte di una media europea del 67.3 per cento, una differenza netta maggiore di 10 punti percentuali) (Allen, 2007). Benché parzialmente distorti dalla politica di trasferimento del prezzo attuata dalla aziende multinazionali, simili osservazioni mostrano un chiaro trasferimento dal salario al profitto, come riconosciuto anche da Teague e Donaghey (2009).
Questo non è stato l'unico elemento a vantaggio delle imprese durante il ventennio di SP. L' “Industrial Relations Act” del 1990 ha reso più difficile la possibilità di sciopero. Nonostante venti anni di social partnership, una legislazione per il riconoscimento dei sindacati è inesistente : l'Irlanda non ha un processo legale obbligatorio tramite il quale un sindacato possa ottenere un riconoscimento da un certo datore di lavoro (Geary 2007, Gunnigle e Heraty e Morley, 2011), ed è quindi lasciata libertà alle imprese di scegliere se contrattare o meno con un sindacato (come confermato dalla Corte Suprema nel 2007 in un caso che riguardava la compagnia aerea Ryanair). Come nota Von Prondzynski (1998), in pratica già il primo accordo di social partnership bloccò i sindacati in un'alleanza “Faustiana” con il governo che rese estremamente più difficile opporsi ad altri aspetti della politica governativa (come i tagli alla spesa pubblica).
È vero che la social partnership non è stata imposta ai lavoratori, ma anzi ha incontrato fra essi un certo favore. Tuttavia, perché mai il capitale indigeno o straniero avrebbero dovuto auspicare una svolta in senso neoliberista del modello di relazioni di lavoro, con tutto il carico di scontri e tensione sociale inevitabilmente insito in essa (basti ricordare gli scioperi dei minatori nella vicina Gran Bretagna), viste le condizioni favorevoli raggiunte sotto la social partnership? Perché rinunciare ad accordi che, come osservò a posteriori un membro dell'Ictu, “diedero alle imprese virtualmente tutto ciò che chiesero – basse tasse sulle imprese, bassi contributi sociali e un mercato del lavoro virtualmente non regolato” (citato in Kirby e Murphy, 2011)?
Eppure, l'agenda dei patti sociali che prevedeva moderazione salariale per “incrementare la competitività”, i pochi diritti per i lavoratori e uno stato sociale minimo non sarebbero stati accettabili per i lavoratori, se l'economia della Tigre Celtica non si fosse basata su un particolare regime di politica economica neoliberale, quantunque non dichiarato, e cioè il “Keynesismo privatizzato” (Crouch, 2009; Bellofiore e Halevi, 2011). Mentre la social partnership era fondata sul fatto che la quota salari e la spesa sociale fossero in diminuzione come percentuale del PIL, il boom economico degli anni della Tigre Celtica sostennero una “cultura di capitalismo naif”, che fece breccia anche fra la forza lavoro (Allen, 2011). Infatti, l'Irlanda non ha mai avuto una sinistra forte. Per la maggior parte della sua storia, i due partiti di centro-destra, Fianna Fail e Fine Gael, si sono assicurati l'80 per cento dei voti. Inoltre, il boom della Tigre Celtica e le istituzioni della social partnership hanno contribuito a creare un approccio corporativistico e acritico ai livelli più alti del movimento sindacale irlandese. Soltanto poche settimane prima del drammatico crollo dell'economia irlandese, ad esempio, il consigliere economicodell'Ictu ha pubblicato un libro celebrativo intitolato “Ireland's Economic Success: Reasons and Lessons” (Sweeney 2008). Come l'autore ha dichiarato con orgoglio nel retro copertina, egli era stato «assistito in questo compito dall'intuito del An Taoiseach Bertie Ahern[12], da Peter Sutherland[13] e da tanti altri importanti uomini d'affari, sindacalisti ed acuti osservatori».
Certamente, molte famiglie appartenenti alla classe operaia beneficiarono di considerevoli guadagni nominali di reddito durante il periodo della Tigre Celtica. Il modello di sviluppo economico della Tigre Celtica ebbe però come effetto una fenomenale esplosione dei prezzi medi delle case di più del 600 per cento, da 62.387 euro nel 1990 a 377.850 euro nel 2007 (CSO 2012a). Questo, a sua volta, ha portato ad una espansione del potere di acquisto delle famiglie irlandesi basato sulla concessione di mutui. Fra il 1993 e il 2008, il debito delle famiglie irlandesi in rapporto al reddito disponibile è cresciuto di più del 400 per cento (McDonough e Dundon 2010). Dopo che i prezzi delle case persero oltre il 50 per cento del proprio valore rispetto al 2007, comunque, la ricchezza nominale di molte famiglie appartenenti alla classe operaia e alla classe media si è rapidamente trasformata in “patrimonio netto negativo”. Il debito immobiliare irlandese eccede ad oggi il valore delle case nel 47.5 per cento dei casi, e il 14.82 per cento dei titolari di mutui è in arretrato coi pagamenti (Kennedy e McIndoe-Calde 2012). Oltre a questo, bisogna considerare che il trenta per cento dei giovani irlandesi e il quindici per cento della forza lavoro sono disoccupati, il che ha costretto molti lavoratori irlandesi a ricorrere, ancora una volta, all'emigrazione. I sindacati irlandesi ed i lavoratori hanno imparato a proprie spese che il loro credo acritico nelle virtù del capitalismo della Tigre Celtica è stato controproducente. Speriamo che la creazione di un nuovo istituto di ricerca economico da parte dell'Ictu (http://www.nerinstitute.net/) non rimanga l'unica lezione appresa durante questa crisi.
Riferimenti bigliografici
Allen, K. (2000), The Celtic Tiger: The Myth of Social Partnership. Manchester: ManchesterUniversity Press.
Allen, K. (2003), Neither Boston or Berlin: Class Polarisation and Neo-Liberalism in the Irish Republic in C. Coulter and S. Coleman (a cura di), The End of Irish History: Critical Reflections on the Celtic Tiger, Manchester, Manchester University Press, pp. 56-73.
Allen, K. (2005), Fianna Fail and Neoliberalism in Studies,93 (372):17-25.
Allen, K. (2007), The Corporate Takeover of Ireland, Dublin, Irish Academic Press.
Allen, K. (2011), After Shock: The Aftermath of the Irish Economic Crash in: M. O Flynn, O. Clarke, P. Hayes, M. Power (eds). Marxist Perspectives on Irish Society. Cambridge: Cambridge Scholars, pp. 171-189.
Baccaro, L. e Simoni, M. (2007), Centralized WageBargainingandthe Celtic Tiger Phenomenon, in: Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 46 (3), pp. 426-455.
Bellofiore, R. e Halevi, J. (2011), Could be Raining: the European Crisis after the Great Recession in: International Journal of Political Economy, 39(4), pp. 5-30.
Birch, K. e Mykhnenko, V. (2010), Introduction, in Birch, K. e Mykhnenko, V. (a cura di), The Rise and Fall of Neoliberalism: the Collapse of an Economic Order?, London, Zed Books, pp. 1-20.
Collings, D.G., Gunnigle, P. e Morley, M. (2008), Boston or Berlin: American MNCs and the Shifting Contours of Industrial Relations in Ireland in: International Journal of Human Resource Management, 19, 2, 240-61.
Crouch, C. (2009), Privatised Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime in: British Journal of Politics & International Relations, 11 (3), pp. 382-399.
CSO (2012a), Average Price of Houses by Year, Statistic and Area in: http://www.cso.ie/
Doherty, M. e Erne, R. (2010), Mind the Gap: National and Local partnership in the Irish Public Sector, in Industrial Relations Journal, 41(5), pp. 461-478.
Dumenil, G. e Levy, D. (2004), Capital Resurgent, Cambridge, MA., HarvardUniversity Press.
Erne, R. (2010), European Unions: Labour's Quest for a Transnational Democracy, Ithaca, NY., CornellUniversity Press.
Erne, R. (2011a), Interest Association in Caramani, D. (a cura di), Comparative Politics, 2nd edition. Oxford, Oxford University Press. pp. 259-274.
Erne, R. (2011b), I sindacati europei dopo la crisi globale, in Quaderni Rassegna Sindacale - Lavori, XII, n. 1, pp 157-175.
Erne, R. (2012), Le relazioni industriali europee dopo la crisi. Verso un interventionismo regolatorio post-democratico? in Quaderni Rassegna Sindacale - Lavori, XIII, n. 1, pp 113-126.
Erne, R. (2013), Let’s accept a smaller slice of a shrinking cake. The Irish Congress of Trade Unions and Irish public sector unions in crisis. in Transfer: European Review of Labour and Research, August, 19 (3), forthcoming.
Ferriter, D. (2004), The Transformation of Ireland 1900-2000, London, Profile Books.
Geary, J.; (2007), Employee Voice in the Irish Workplace: Status and Prospect in: Freeman, R. Boxall, P. e Haynes, P. (a cura di). What Workers Say: Employee Voice in the Anglo-American World. Ithaca, CornellUniversity Press, pp. 97-123.
Gunnigle, P. e Heraty, N. e Morley, M. J. (2011), Human Resources Management in Ireland, Dublin, Gill&MacMillan.
Hardiman, N. (2002a), From Conflict to Co-ordination: Economic Governance and Political Innovation in Ireland, in West European Politics, 25(4), pp. 1-24.
Hardiman, N. (2002b), The Development of the Irish Tax State, in Irish Political Studies, 17(1), pp. 29-58.
Harvey, D. (2005), A Brief History of Neoliberalism, Oxford, OxfordUniversity Press.
Johnston, L. (2009), The Rising Tide that Failed to Lift all Boats: Poverty, Inequality and the 'Celtic Tiger', in Limerick Student Journal of Sociology, 1(1), pp. 71-90.
Kennedy, G. e T. McIndoe-Calde (2012), The Irish Mortgage Market: Stylised Facts, Negative Equity and Arrears. in Quarterly Bulletin of the Central Bank of Ireland, n.1., pp. 85-108.
Kirby, P. (2009) Irlanda: Il collasso della 'tigre celtica', in Il Mulino, Vol. LVIII, No. 442, 2/09, 254-262.
Kirby, P. (2010), The Celtic Tiger in Collapse: Explaining the Weakness of the Irish Model, Palgrave Macmillan.
Kirby, P. e Murphy M. P. (2011), Towards a Second Republic. Irish Politcs after the Celtic Tiger, London, Pluto Press.
Labour Relations Commission (2013)Draft Public Service Agreement 2013– 2016. Dublin, 23 February 2013. Available at:
McDonough, T. e Loughrey J. (2009), The H.E.A.P Chart: Hierarchy of Earnings, Attributes and Privilege Analysis, Dublin, Tasc, http://www.tascnet.ie/upload/file/9644%20HEAP%20BOOKLET%281%29.pdf.
McDonough, T. e T. Dundon (2010), Thatcherism Delayed? The Irish Crisis and the Paradox of Social Partnership, in Industrial Relations Journal, 41 (6), pp. 544-562.
Ò Riain, S. (2004), The Politics of High-Tech Growth. Developmental Network States in the Global Economy, Cambridge, CambridgeUniversity Press.
Ò Riain, S. (2012), The Crisis of Financialisation in Ireland, in The Economic and Social Review, 43(4), pp. 497-533.
O’Hearn, D. (2003), Macroeconomic Policy in the Celtic Tiger, in Coulter, C. and Coleman, S. (a cura di), The End of Irish History: Critical Reflections on the Celtic Tiger, Manchester: Manchester University Press, pp. 34-55.
O'Connor, E. (2011), A Labour History of Ireland: 1824-2000, Dublin, UCD Press.
O'Toole, F. (2003), After the Ball, Dublin, Tasc/New Island.
Regan, A. (2012), The Political Economy of Social Pacts in the EMU: Irish Liberal Market Corporatism in Crisis, in New Political Economy, 17(4), pp. 465-491.
Roche, W. K. (2007), Social Partnership in Ireland and New Social Pacts, in Industrial Relation, 46(3), pp. 395-425.
Roche, W. K. (2012), After the Ball is Over: Accounts of the Functioning and Demise of Social Partnership, in Sheehan, B. (a cura di), The Labour Relations Commission. Recalling 21 Years: 1991-2012. Dublin: LRC, pp. 113-150.
Roche, W. K. e Cradden, T. (2003), Neocorporatism and social partnership, in Adshead, M. e Millar, M. (a cura di), Public Administration and Public Policy in Ireland, London, Routledge, pp. 69-87.
Roche, W. K. e Geary, J.; (2006), Partnership at Work: The Management of Radical Organizational Change. London, Routledge.
Saad-Filho, A. (2011), Crisis in Neoliberalism or Crisis of Neoliberalism?, in Panitch, L.; Albo, G.; Chibber, V. (a cura di), The crisis this time, London, The Merlin Press, pp. 242-259
Schmitter, P. C. e Grote, J. (1997), The Corporatist Sisyphus: Past, Present and Future, in EUI Working Paper, SPS No. 97/4.
Sheehan,B. (2012), Government on track to meet targets due to cuts in public service spending in: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/07/articles/ie1207019i.htm
Sweeney, P. (2005) Selling out? Privatisation in Ireland, Dublin, New Island Publications.
Sweeney, P. (2008) Ireland's Economic Success: Reasons and LessonsDublin, New Island Publications.
Teague, P. e Donaghey , J. (2009), Why has Irish social partnership Survived?, in British Journal of Industrial Relations, 47(1), pp. 55-78 .
Von Prondzynski, F. (1998), Ireland: Corporatism Revived, in Ferner, A. e Hyman, R. (a cura di), Changing Industrial Relations in Europe, Oxford, Blackwell, pp. 55-73.
Whelan, K. (2012) ELA, Promissory Notes and all that: the Fiscal Costs of Anglo Irish Bank. UniversityCollegeDublin. School of Economics Working Paper 2012-02.
Note
[1] Roland Erne è docente di relazioni industriali europee e comparate, School of Business, University College Dublin. Vincenzo Maccarrone è Allievo Senior, Collegio Carlo Alberto, Torino e studente presso l’Università di Torino
[2] Tra il 2000 e il 2008, un periodo in cui le principali banche irlandesi sono cresciute più del 300%, il capitale produttivo investito dalle imprese è aumentato soltanto del 26% (Ò Riain, 2012).
[3] I soli pagamenti del debito della Anglo-Irish Bank, al tempo terza banca privata del paese per dimensione, costeranno all'Irlanda 47 miliardi di Euro (Whelan, 2012). Ciò graverà su ciascun lavoratore irlandese per una quota superiore a 26000 euro.
[4] “Guerrieri del destino” in Gaelico.
[5] “Famiglia degli irlandesi”.
[6] La Confederazione dei sindacati irlandesi.
[7] Mentre i cinque azionisti di maggioranza succedutisi alla guida di Eircom hanno indebolito la compagnia, guidati dal solo fine di guadagnare profitti nel breve periodo, il tutto a scapito del pubblico interesse, i 14.000 lavoratori ed ex dipendenti di Eircom hanno ricevuto, in media, circa 62.500 Euro a testa, dall'Employee Share Ownership Trust (Irish Times, 31 May 2012), istituito al fine di assicurare la condiscendenza dei lavoratori e dei sindacati con l'agenda di privatizzazioni portata avanti dal governo.
[8] Primo Ministro
[9] Come riconosciuto da Collins, Gunnigle e Morley (2008) e da McDonough e Dundon (2010) sarebbe forse più corretto utilizzare il termine “adversarial” (conflittuale) invece che “antagonistic” (antagonista) per descrivere il sistema di RI irlandese. Tuttavia come gli autori sopracitati si preferisce rimanere fedeli all'impostazione originaria di Von Prondzynski (1998).
[10] La Labour Court è un organo di riconciliazione e non un tribunale vero e proprio. È un ente tripartito che ha il compito di dirimere controversie riguardanti le relazioni industriali e le condizioni di lavoro. Se si escludono alcune eccezioni, i suoi giudizi non hanno valore legislativo ma si limitano a dare un parere sulla controversia ed a suggerire i termini in cui la controversia fra le parti in causa vada risolta. Esso è una “corte di ultima istanza”: ci si rivolge alla corte quando siano falliti altri tentativi di risolvere la disputa.
[11] La LRC nata nel 1991 allo scopo di migliorare le RI irlandesi, tramite l’offerta di una gamma di servizi per sindacati, lavoratori ed imprese che comprende, fra gli altri, un servizio di conciliazione fra le parti per cercare di evitare che la disputa venga risolta dalla Labour Court.
[12] Al contrario di quanto atteso, nel referendum svoltosi nel mese di aprile, i lavoratori hanno bocciato la nuova proposta di accordo.
[13] Caduto in disgrazia a seguito di un caso di corruzione venuto alla luce quattro mesi prima dello scoppio della crisi.
[14] Direttore non esecutivo di Goldman Sachs, predecessore di Mario Monti come direttore europeo della Commissione Trilaterale e Commissario Europeo alla concorrenza.