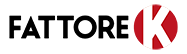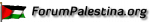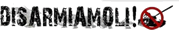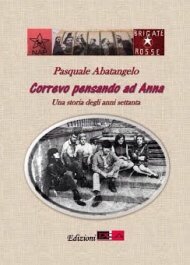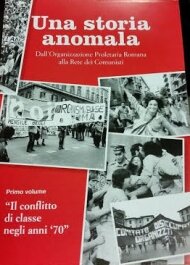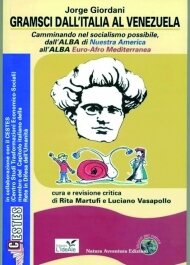Il movimento dei lavoratori e la nozione storica di “egemonia” (II parte)
- di Alessandro Mazzone
- Categoria: documenti
- Visite: 587

Il sentimento dell’oppressione non si risolve nello “invidioso confronto” con i più fortunati (J.M. Keynes), non è “risentimento” per la propria sorte (M. Scheler), non si spiega col fatto che, a differenza di quanto avveniva nella società tradizionale, preborghese, la massa della popolazione è in grado di confrontare continuamente la propria condizione con altre (B. Russell).
Queste teorizzazioni appartengono al sociologismo povero, che parte da astratti “individui” come dati, e poi li riferisce gli uni agli altri – quasi che gli “individui” fossero pensabili prima e al di fuori del processo sociale di cui sono, essi sì, i luoghi dell’azione. Il “confronto”, caso mai, è tra le possibilità umane che, in una data fase dello sviluppo storico, sono obiettivamente aperte e pensabili, e solo perciò diventano anche più o meno confusamente, immaginabili.16 Queste possibilità umane esistono obiettivamente. Il problema non è se esse siano attuabili “per tutti” (“tutti ingegneri”, “tutti medici”, ma anche “tutti operai” è evidentemente fuori questione.) Ciò che ad esse è comune obiettivamente è la realizzabilità materiale: p. es., oggi, sarebbe possibile (in un Paese avanzato) ridurre drasticamente la giornata lavorativa, garantire alloggio, istruzione, assistenza sanitaria. (Ci si torna più avanti.) La realizzabilità materiale (le “risorse”, non solo economiche ma anche di capacità, abilità soggettive) non è ancora, beninteso, realizzabilità sociale, o politica – ma quella è condizione di questa, è ciò che la rende possibile. Questo possibile obiettivamente inerente a un dato grado di sviluppo umano, cioè sociale, è quello che G. Lukàcs chiama “genericità” o “adeguatezza allo sviluppo del genere umano” [1]: adeguatezza che può realizzarsi, una volta raggiunta, con la produttività del lavoro, la realizzabilità materiale, ma solo attraverso tutta la vita sociale, dunque attraverso le lotte sociali, politiche, culturali, che – in una società di classe – sono, nel loro complesso, come unità in movimento, lotte egemoniali per la l’affermazione di quei rapporti di produzione e di riproduzione sociale complessiva (di produzione e riproduzione di uomini) che siano adeguati e conformi alla riproduzione e al potere della classe che si pone come egemone, o che lo è già diventata.
Non si tratta dunque di negare o svalutare il sentimento dell’oppressione, ma sì di intendere ciò che esso è. Come sentimento, esso è nell’animo dei singoli; e non è ancora chiaro pensiero, né azione razionale. Confusamente, c’è in lui la percezione del non attuarsi, in sé o in chi è prossimo, di quello che “sarebbe umanamente possibile, se… le cose stessero altrimenti, se… l’oppressione cessasse, se…”. Finché resta chiuso nel sentire, questo “se” può arrivare al triste “dovrebbe essere” della coscienza morale, che si sa nel giusto (“dovrebbe essere così, ma non è”) e contemporaneamente nell’impotenza (“non è, anche se dovrebbe essere”) [2]. Ma non esce dal “qui ed ora”, non diventa processo, pensiero-azione. Il pensiero razionale e l’agire che è a lui adeguato, ed è suo, sono sempre collettivi; diventano esperienza della contraddizione obiettiva, del lavoro e della lotta per superare quel “sarebbe giusto, ma…” in cui la coscienza astratta si blocca. Il pensiero, a differenza del mero sentire, non può restar chiuso nell’animo mio, o uscirne come semplice grido e impulso di rivolta. Esso esce fuori nel mondo degli uomini, è comunicazione e linguaggio per definizione, si misura con gli altri (“discussione”), e con le cose: è ragione che conosce e modifica il mondo. È, in generale, la forma in cui si muove il mondo degli uomini, e perciò è obiettivo, e storico [3].
Tutto questo va bene (dirà forse qualcuno). Ma (ecco l’obiezione)
questo pensiero razionale, collettivo, obiettivo, storico, hai appena detto che diventa lotta per attuarsi, per costruire un mondo adeguato. E questa lotta, che appunto non ha da essere sogno o mera rivolta – che possibilità ha, in pratica?
- A questa obiezione, una volta fatta, non si sfugge. E non si può neppure cercar di aggirarla, predisponendo “in teoria” le condizioni di un processo, che appunto è di lotta, e lotta storica, e non uno schema, o un meccanismo ripetitivo. E allora? Allora – c’è l’ esperienza, collettiva anche lei (manco a dirlo), che non permette di predire l’andamento di questa lotta qui, ma ha insegnato e insegna. E qualche conclusione teorica, sì, la permette.
Rivolta, si sa, non è rivoluzione. E non è neppure transizione. “Transizione” a un’ altra formazione sociale vuol dire transizione a un’altra situazione egemonica, all’egemonia di un’altra classe, a rapporti di produzione diversi; e quindi, nel tempo, a modi nuovi di produzione e di vita, per tutti i membri della società. Queste transizioni, nella storia a noi nota, sono avvenute per lo più tramite rivoluzioni e cicli di rivoluzioni, costituendo e ricostituendo nuovi blocchi storici [4], o unità-in-movimento, più o meno stabili, di classi egemoni e classi subalterne. Ma qualunque forma abbiano avuto quelle lotte, esse furono, in quanto capaci di portare alla transizione, lotte egemoniali [5], che portavano a instaurare una nuova egemonia di classe. Oppure non arrivarono a tanto – quando si cercò di rompere l’egemonia della classe dominante, la si costrinse in alcuni casi a un compromesso, la si spinse a modificare il blocco storico con le classi subalterne, (come avvenne nelle fasi di crescita della borghesia prima e poi del movimento operaio): e si trattò allora di conflitto tra un’egemonia sussistente e una potenziale, o soltanto in fieri.
Opera qui un’altra distinzione gramsciana importante, quella tra classe dirigente e classe dominante. Il primo termine vale per una classe capace, nell’attuare le sue istanze, di realizzare anche istanze di altre classi, pur subalterne – così la borghesia nella fase espansiva e rivoluzionaria. Il secondo vale per una classe che è dominante ancora, ma non più espansiva, non più capace di assimilare segmenti di altre classi alleate o subalterne, e che tende a trasformarsi in gruppo privilegiato o in oligarchia [6].
Si è detto che “egemonia” è una categoria storica. Nelle rivoluzioni borghesi classiche (come l’ olandese e l’ inglese nel ’600, la americana e più la francese nel ’700) le rivendicazioni antiassolutistiche e antifeudali della borghesia si presentavano come affermazioni di diritti. Diritti civili, tra cui: libertà di compravendita e di iniziativa per tutti, che implicava distruzione dei vincoli corporativi e proprietà immobiliare piena, cioè fine dei diritti-doveri di signore e servo sulla terra; libertà di movimento delle persone, cioè instaurazione di un diritto inerente a-priori all’individuo, indipendente dalla concessione di privilegi da parte dei detentori di autorità [7], e distruzione dei privilegi stessi; con questo, uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e distruzione delle giurisdizioni privilegiarie, d’ordine o di ceto. – Diritti politici: libertà di religione, di manifestazione del pensiero, di stampa, di associazione; diritto elettorale, ma non suffragio universale [8].
Facendo trionfare in tutto o in parte queste rivendicazioni, che si presentavano come ideali “umani”, come “diritti dell’uomo”, la borghesia apriva di fatto nuove vie di sviluppo e di autorealizzazione anche ad elementi o frazioni delle classi subalterne [9]. L’accesso alla proprietà borghese, cioè all’artigianato, alla piccola industria, al commercio, collegati all’urbanizzazione, è stato per generazioni uno stimolo potente di integrazione di frazioni consistenti di popolazione, e ciò in senso obiettivo, cioè economico, e anche soggettivo. L’espansione economica complessiva, portato della produzione capitalistica, permetteva ed esigeva nuove imprese, nel commercio, nei trasporti, meno spesso nell’industria vera e propria: se era ridicolo predicare agli operai “Diventate capitalisti!” (ma lo si predicò), non pochi piccoli capitalisti, nell’’800 e ancora in parte nel ’900, ebbero un nonno operaio. (Si parla sempre, qui, dei Paesi borghesi “classici”, diventati poi metropoli imperialiste.) – Ancora: l’istruzione pubblica apriva la via delle professioni a una minoranza di “capaci e meritevoli”, che venivano integrati, talvolta nel corso di due-tre generazioni, nel ceto medio borghese. Ancora, e più in generale: il capitale non crea la scienza, ma la usa, e quindi la esige: la scienza è infinita, crea linguaggi universali, e può (non: deve necessariamente) contribuire a creare forme di linguaggio e coscienza universalmente umane.
In breve: la borghesia “classica” era una classe espansiva, capace di integrare in sé elementi di altre classi, e di assimilarli. E fu, nella fase pre-imperialistica, una classe progressiva: nel senso primario e obiettivo, che lo sviluppo indefinito della produzione capitalistica aveva una funzionecivilizzatoria [10]: la generalizzazione della produzione di merci rompeva l’idiotismo localistico, metteva gli uomini in contatto con un mondo più vasto, li spingeva a cercare strade sempre nuove -sebbene queste strade, per i più, fossero poi quelle dello sfruttamento spietato, ma nello sviluppo della produttività del lavoro sociale. E nelle vicende politiche, fin verso il 1870: finché le rivendicazioni antifeudali e di libertà abbattevano ostacoli all’espansione capitalistica e all’egemonia borghese in tutte le sfere della società, e non aprivano la porta, nella loro “contaminazione” con esigenze democratiche, p. es. il suffragio universale, l’istruzione generale e gratuita, al proletariato e alle nuove classi subalterne, la borghesia in generale le portò avanti, le sostenne, e spinse il “popolo” a battersi per esse.
- Ma l’obiezione, giustamente, ritorna. E allora? – si dirà. Tutto questo è acqua passata. Queste lotte egemoniali, i blocchi storici che la borghesia ha costruito e rimodellato quando minacciavano di rompersi, sono storia di ieri. Noi ne veniamo, e perciò è bene studiarle e capirle. Ma ora? Quali prospettive può avere una lottaegemonialechenonmiria instaurare l’egemonia della borghesia (progressiva in altri tempi, ma ora no davvero…), ma rapporti di produzione e di vita che vadano al di là del capitalismo in quanto fondamento dell’ egemonia borghese?
Qui la considerazione teorica, concettuale, può fare ancora una deduzione, e un rimando.
La deduzione è questa: se, e nella misura in cui, le lotte attuali e future prossime riusciranno a essere lotte per l’egemonia, cioè per trasformare la realizzabilità materiale di nuovi rapporti di produzione e di vita (che c’è, sostanzialmente), in prospettiva effettiva dell’attuazione di questi rapporti (e dunque sia nelle cose, nelle istituzioni economiche, civili, politiche, della formazione, che negli uomini, nel loro modo di essere, di pensare sé stessi e gli altri, di agire collettivamente) –allora queste lotte, e tutto quello che le prepara nella conoscenza e nell’organizzazione, non saranno soltanto rivolta, o resistenza nobile ma residuale, e simili, ma avvio alla transizione. Quanto questo avvio sarà lungo, tortuoso, con quali processi rivoluzionari, e altri, la deduzione concettuale non può dire. [11]
In secondo luogo, il rimando all’esperienza. C’è stata una lotta egemoniale, non per l’instaurazione dell’egemonia borghese, ma per il suo superamento, nel passato recente, in vari Paesi, e anche in Italia? Certo che c’è stata, e si chiamava comunemente (fino agli anni ’70 circa) lotta per l’egemonia della classe operaia, nel secondo blocco storico italiano recente, quello uscito dalla lotta antifascista,dal “Secondo Risorgimento”, e dal compromesso di classe (solo e vero compromesso “storico”) iscritto nella Costituzione della nostra Repubblica (Art. 1: “Repubblica democratica fondata sul lavoro”).
L’Italia uscita dalla seconda guerra mondiale era un’epitome del mondo di allora (come la Russia,mutatis mutandis, lo era stata all’inizio del ’900). Era innanzitutto un Paese industriale, con un capitalismo avanzato, ma con una semicolonia interna, il Mezzogiorno. Era poi un Paese in cui la borghesia aveva abbandonato la sua funzione nazionale, perseguendo un progetto di imperialismo subalterno (lo “imperialismo straccione” dell’inizio del secolo, fino al c.d. “intervento” del 1915, e all’insensata “guerra parallela” del 1940). Un Paese a sovranità limitata dal 1938, e la cui sovranità era stata restaurata, in parte, grazie all’azione della classe operaia nella Resistenza. Un Paese la cui borghesia cercò e trovò, dopo il ’45, una nicchia nel nuovo mercato mondiale configurato dalla prevalenza industriale e monetaria statunitense, basandosi prevalentemente sui bassi salari, piuttosto che sulla ricerca e l’innovazione, salvo quella importata. E dove però la borghesia, con il forte sviluppo industriale degli anni ’50 e ’60, e pur continuando l’emigrazione di massa, seppe dare una grande risposta di classe alla sfida della “unità degli operai dei contadini”, del Nord e del Sud, svuotando le campagne e introducendo, entro certi limiti, un regime di alti consumi e di protezione sociale. Quando questo regime fu di nuovo sfidato, alla fine degli anni ’60, da lotte che si proponevano l’instaurazione di diritti sociali per la sanità, l’alloggio, i trasporti, la previdenza, l’istruzione pubblica e generale fino alle scuole superiori, insomma per una sicurezza di vita di ogni lavoratore nella “Repubblica fondata sul lavoro”, e dunque per l’apertura di prospettive di sviluppo umano quanto meno per chi volesse e sapesse perseguirle [12] – quando, dico, queste rivendicazioni furono poste e sembrarono per qualche tempo attuabili, vi fu chi parlò di “introduzione di elementi di socialismo” nella vita della nostra Repubblica, pur Paese capitalista (e imperialista-subalterno). Sbagliava?
Qui si tratta solo, per noi, di sviluppare la nozione di egemonia e di lotta egemoniale [13]. La lotta politica può modificare comportamenti collettivi, e ottenere cambiamenti nell’ordinamento, nelle istituzioni pubbliche. Sancire dei diritti sociali non significa ancora realizzarli nella vita di tutti e di ciascuno (come sappiamo anche troppo bene): occorre per questo una grande forza politica, organizzativa, morale, capace di indurre un cambiamento molecolare nella vita pubblica, una volontà di servizio pubblico negli addetti, in alto e in basso, e uno spirito pubblico democraticonell’ educazione, nella formazione specifica, nella stampa, nei c.d. media, ecc. Supponiamo, per ipotesi, che anche a questo si potesse giungere, nella fase di avanzamento democratico che sembrava aprirsi verso il 1970 [14]. Questa ipotesi non si scontra senz’altro con i limiti che, continuando il Modo di produzione capitalistico, sono posti in generale alla realizzazione di diritti sociali. La borghesia ha potuto essere indotta a questa sorta di compromessi storici, per es. in alcuni Paesi europei, nella fase c.d. “fordista”, e della presenza di un sistema concorrente, il “campo socialista” (che si presentava come uno dei “tre reparti” del movimento democratico mondiale, gli altri due essendo la classe operaia dei Paesi industrializzati, e il movimento di liberazione dei Paesi “periferici”). Ma certamente la instaurazione piena dei diritti sociali, che appunto non sono, per la forma della loro realizzazione, assimilabili ai “diritti civili” e “politici” delle rivoluzioni democratico-borghesi classiche, non poteva non urtarsi, da un lato con le esigenze del capitale in genere, dall’altro con tutte le forme giuridiche, amministrative, di vita associata, che l’egemonia borghese aveva instaurato, in modi diversi, nei singoli blocchi storici, cioè nelle nazioni e Stati borghesi moderne.
Questa è la questione di egemonia – cioè dei rapporti di forza tra le classi, che naturalmente si pongono e modificano non solo nei singoli Paesi, ma ormai in tutta la Formazione economico-sociale, di cui i singoli Paesi, nella fase imperialistica, sono segmenti. L’ipotesi fatta qui sopra avrebbe implicato una lotta egemoniale, condotta dal movimento di classe e democratico del periodo in questione, e capace di far valere diritti sociali, che – se realizzati fino in fondo, a cominciare dal diritto al lavoro – vanno al di là dell’orizzonte borghese.
Ma resta vero che oggi, in un Paese avanzato, si potrebbe ridurre drasticamente la giornata lavorativa, garantire reddito di lavoro per tutti, istruzione previdenza sanità alloggio per tutti, ecc.? In astratto, certo, resta vero. Però: la realizzabilità materiale, appunto, non è ancora realizzabilità concreta (ne è la condizione di possibilità, come abbiamo visto.)
E tuttavia, la realizzabilità materiale dei diritti sociali non è scomparsa.. È vero: trent’anni dopo, in presenza delle rovine di quei diritti sociali, e della nuova tappa dell’imperialismo [15], si tratta innanzitutto di vedere come la borghesia, essa stessa mutata, non più espansiva ma oligarchica, modifica il suo blocco storico di classi subalterne, e di popoli subalterni nella “periferia” ricapitalistizzata e ricolonizzata. E, senza dubbio, si tratta di ricominciare dopo una grande sconfitta. Ma chiunque affermi seriamente che l’orizzonte, non importa quanto lontano, è quello di una fuoruscita dal Modo di produzione capitalistico, pone una questione di lotta egemoniale, e ha obbligo di pensare conseguentemente, e indicare, come ritiene possa configurarsi un soggetto di classe di questa lotta.
Non importa qui se tale soggetto sia pensato come tutto da ricostruirsi in un lavoro e una lotta assai lunga, ecc. – La questione è un’altra: chi afferma (come Hardt e Negri, ma non solo) che la transizione non avrà più un soggetto di classe, afferma con ciò stesso di pensare a una transizione (rivoluzionaria??) diversa nel genere, imparagonabile a tutte le transizioni e trasformazioni sociali del mondo moderno, borghesi o socialiste che fossero. Anche questo è lecito, beninteso. Ma ha alcune conseguenze. Non si tratta solo dei mezzi politici (non violenza, Gandhismo, movimentismo ecc.). Si tratta di fondare e argomentare razionalmente un progetto storico senza precedenti storici, e senza riscontri nella costituzione di classe che è pur quella del presente. Se se ne è capaci, lo si faccia. Ma qui non valgono le frasi (“situazione inedita”, “postmodernità” “fine della storia”, “fine del lavoro” e via vaticinando [16]).
[1] Nella Ontologia dell’essere sociale, e nei postumi Prolegomeni all’ontologia dell’essere sociale. Tr. it. Milano, Guerini & associati, 1990.
[2] Quasi 200 anni fà, di fronte al primo romanticismo, G.W. F. HEGEL mostrava come questa coscienza morale astratta si sviluppasse in moralismo, ironia “disincantata”, e ipocrisia. (Cfr. p. es. Fenomenologia, 1807, cap. IV; Filosofia del diritto, 1821, § 140: quest’ultimo testo è ben leggibile anche per i non specialisti.) – I pensatori “postmoderni” oggi di moda spargono a piene mani quel “disincanto” e quella ipocrisia. Certo, io mangio e bevo, so bene che intanto migliaia muoiono di fame e di sete, e, come individuo privato e isolato, non posso farci nulla. Questa consapevolezza è intollerabile, il pensatore “postmoderno” mi spiega come posso toglierla di mezzo col “disincanto” e la imperturbalità – e così non vado avanti, non penso che, essendoci in verità le “risorse”, la realizzabilità materiale, il superamento di quella morte per inedia e in verità sterminio è oggi possibilità reale; la quale può diventare possibilità concreta attraverso una lotta egemoniale, certo non breve, per condizioni di riproduzione degli uomini che vadano al di là del capitalismo imperialistico. Il risultato “postmoderno” è che non penso razionalmente, praticamente, e non agisco collettivamente, con altri uomini, in organizzazioni, strutture, istituzioni che sono appunto e sole quelle dell’effettivo agire. (Mentre per la coscienza morale astratta e il suo sentire, doloroso o indifferente e disincantato, basta la privata interiorità, l’immediato sentire, che può essere condiviso qui ed ora con altri, diventare magari vampata di ribellione, ma non processo collettivo, duraturo, conscio di cause ed effetti, costruzione di una alternativa.)
[3] Qui devo chieder venia al paziente lettore. Sì, si tratta di concetti filosofici, bisogna fare uno sforzo per ripensarli in proprio. Anche se chi scrive ha fatto il suo lavoro per bene, ha mostrato la via passo passo (che non è detto), quello sforzo di ripensare in proprio non si lascia togliere. Si rifletta a questo. Un pensiero politico che non è azione è… un ferro di legno. Se è pensiero, riflessione razionale, esso non influisce solo su coloro a cui viene comunicato, ma prima di tutto su chi lo pensa. Faccio una riflessione politica vera (non un piagnisteo generico sulla malvagità o l’ignavia umana…), ho mutato la mia percezione del corpo sociale di cui sono elemento. Ma con ciò ho cambiato me stesso, di tanto o poco, nel mio rapporto col mondo: agisco, a partire da ora, con altri e sul mondo, in modo diverso da prima. Questa è – in vitro – “unità di teoria e prassi”.
Ma si tratta, qui, anche di capire perché l’avversario di classe, la tirannide moderna NON voglia che noi pensiamo, che usciamo dal vago e ribelle sentire l’oppressione e l’ingiustizia, e pensandone invece le modalità, il fondamento, la struttura, ci attrezziamo per combatterle.
[4] Nozione e termine che risalgono ai Quaderni del carcere di A. GRAMSCI. Così per il blocco storico che risulta dal Risorgimento italiano nell’’800: la borghesia come classe egemone alleata alla proprietà terriera semifeudale, attraverso un compromesso che escludeva trasformazioni democratiche; quindi la piccola borghesia commerciale e artigiana, e la classe operaia e i contadini, cioè la grande maggioranza della popolazione, in vario grado di subalternità. Tutto questo non esaurisce il carattere progressivo della rivoluzione borghese in Italia: qualcosa cambia anche per frazioni importanti delle classi subalterne. Ma nel breve corso di una generazione, già a fine ’800, avremo lo scontro diretto tra reazione e primo movimento operaio.
[5] Sembra opportuno distinguere tra questo tipo di lotte storiche, e l’esercizio quotidiano dell’egemonia nelle varie sfere della vita sociale. Per quest’ultimo si usa, e mantengo, l’aggettivo “egemonico”. Così il rapporto di capitale è egemonico, è fondamento dell’ egemonia borghese, e via dicendo.
[6] Questo valeva per le borghesie dominanti al tempo di Gramsci. E sembra valere ancor di più per l’attuale oligarchia economico-politico-finanziaria.
[7] Tali erano i “diritti” di corporazioni, città, o anche singoli, che il Medioevo conosceva: così le varie carte, statuti, ecc., i cui documenti erano gelosamente conservati, e che risalivano ad atti d’autorità regia o, in subordine, feudale.
[8] I diritti politici non furono mai riconosciuti pienamente alle classi subalterne dalle rivoluzioni borghesi. Anche con la Rivoluzione francese, la famosa legge Le Chapelier (1791) vietava le associazioni operaie. La libertà di religione trovò limiti in Europa: nella “questione ebraica”, ossia della emancipazione degli israeliti. Solo la Costituzione giacobina (1793), mai attuata, previde il suffragio universale – lo si ebbe poi nel 1848, ma solo per affossare la Seconda Repubblica (e non per caso Marx analizzò questo svolgimento nelle Lotte di Classe in Francia e nel 18 Brumaio di Luigi Buonaparte); quanto al suffragio femminile, bisognerà attendere il XX secolo. – Per i grandi classici del pensiero liberale, a cominciare da J. Locke, il suffragio universale, che in linea di principio darebbe alla maggioranza dei non-possidenti il potere sui possidenti, è un’assurdità.
[9] Caso tipico, la liberazione dei contadini – cioè dell’immensa maggioranza della popolazione – dalle servitù feudali; e la possibilità, aperta ai più agiati di loro, di accedere alla proprietà della terra. In Francia, questi nuovi piccoli proprietari furono poi soldati e sostenitori di Napoleone I.
[10] Anche questo è un tema su cui Marx ritorna più volte, tanto in Capitale III, sez. VII, quanto nei 3 grandi manoscritti preparatori.
[11] Questa deduzione non è che l’esplicazione del concetto di egemonia e di lotta di egemonie – in questo senso può dirsi che essa, poste le premesse, è tautologica.
[12] C’è bisogno di dire che il c.d. “tempo libero” sta alle prospettive di sviluppo umano al massimo come condizione necessaria, non sufficiente, poiché può essere riempito di qualunque cosa, essendo appunto “libero” in quanto vuoto, semplice “tempo di non-lavoro”? Più sostanziale, in quella fase, era la rivendicazione “la Costituzione non solo fuori, ma anche dentro i luoghi di lavoro”.
[13] La opportunità politica delle varie posizioni di allora è, ovviamente, un discorso a parte.
[14] Si avviava invece allora, come oggi sappiamo, la grande controffensiva del capitale su scala mondiale, che tuttora mostra i suoi effetti. La nostra ipotesi è dunque, come si dice, controfattuale.
[15] Cfr. G. GATTEI, Tre maniere dell’imperialismo, nel vol. Il piano inclinato del capitale. Crisi, competizione globale e guerre, a cura di L. VASAPOLLO. Milano, Jaca Book, 2003.
[16] Si può anche affermare che la classe operaia, cioè il capitale, il rapporto di produzione fondamentale, il Modo di produzione capitalistico, non esistono più. Ci si dica allora, ma non a frasi, non a brandelli di mode “filosofiche” e di “analisi” politiciste, che cosa esiste, e in che mondo viviamo.